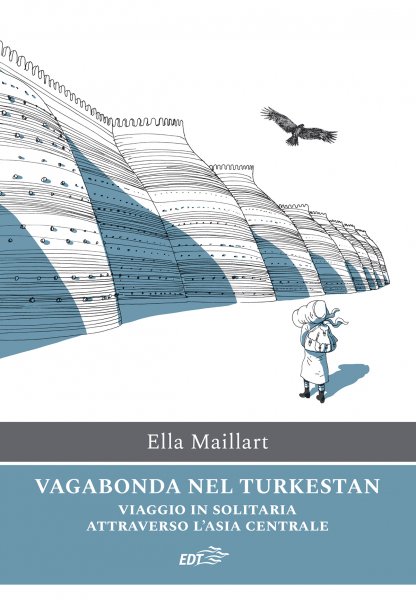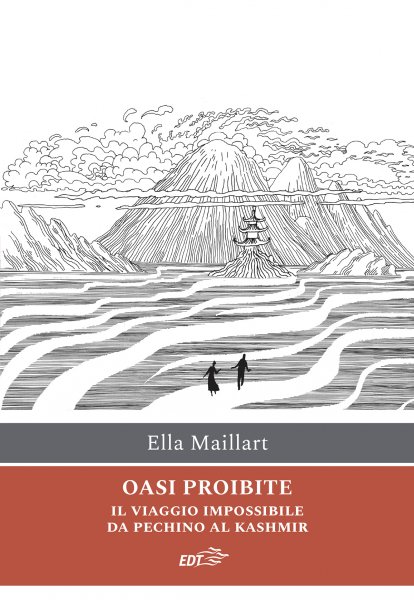Ella Maillart: tra il Turkestan russo e la Cina

Due grandi viaggi nel cuore dell'Asia. Uno in solitaria, l'altro in compagnia di Peter Fleming, giornalista del «Times».
Prima il Turkestan russo, da Alma Ata (Almaty) a Kazalinsk (oggi Kazaly, in Kazakistan): un documento di straordinario interesse e grande vivacità sulla periferia dell’Unione Sovietica. Poi la traversata della Cina da Est a Ovest, le oasi “proibite” dello Xinjiang, da mille anni culla di un’antica cultura di origine iranica, il deserto del Taklamakan e infine il Kashmir, dall’altra parte del mondo, attraverso le mulattiere del Pamir e del Karakoram.
Proponiamo due brevi estratti da Vagabonda nel Turkestan e Oasi proibite, classici del catalogo EDT di nuovo in libreria nella collana Ancore.
Ella Maillart (1903-1997), ginevrina, è stata scrittrice, fotografa, velista e sportiva olimpionica. È forse la più celebre viaggiatrice/scrittrice del Novecento, e ha dedicato alle sue intense e coraggiose peregrinazioni molte opere oggi considerate grandi classici della letteratura di viaggio, fra cui Oasi proibite, Vagabonda nel Turkestan, Crociere e carovane, La via crudele e Ti-Puss, tutte pubblicate da EDT.
Non mi stanco mai di osservare la vita intorno a me. Vi sono vie brulicanti di traffico indigeno. «Posht!, “Attenzione!”, urlano gli asinai e gli arbakeš facendosi strada tra la folla che compra e che vende quel che può.
Accovacciata contro un muro, ascolto il flusso e il riflusso di questa umanità vagante: sono in un formicaio e capisco finalmente dove sta andando ogni formica.
Due figli del deserto, riconoscibili dalla pelle abbronzata e dal passo lento e sicuro, esaminano del kišmiš, ne assaggiano i piccoli acini, poi chiamano un terzo compagno che porta stivali kazaki dai tacchi a punta e fiosso alla Luigi XV. Il prezzo richiesto suscita la loro ilarità e così si allontanano.
Molti hanno grandi turbanti di lana grigia, assai pratici per portare, protetti tra due torciglioni, vetri di lampade. Sotto la rotonda coperta della piazza, dove ancor più si accalca la gente, scoppia una risata generale quando un tiro di buoi si mette a spingere con le corna i passanti.
Un venditore di mele grida di continuo contro quelli che sostano troppo a lungo davanti al suo banco. Due afghani con turbante nero sono tentati da un taglio di rasatello giallo in possesso di un russo che dice: «Guardate quanti metri sono, avete solo da contarli, ci sono tutti!». Un terzo si presta a fare da interprete.
Alcune donne vendono inqualificabili cianfrusaglie. Ma se viene offerto un tappeto di Bukhara, un tekinski, o una maiolica cinese, scompaiono nel giro di pochi minuti, acquistati da intenditori che vedo ogni giorno alla ricerca di un buon affare. Un piccolo pezzo di tekiner, tappeto di colore scuro lavorato dalla tribù dei Teki, vale cento rubli ed è soprattutto utilizzato per confezionare i kurdjun, le bisacce di cui ogni indigeno carica l’asino, il cavallo o il cammello. Mi dicono che i loro disegni geometrici rappresentano in forme stilizzate la jurta al centro del grande pascolo, l’aryk che lo solca, i fiori e il cavallo nel campo.
La mia vicina di camera ha comprato due braccialetti e un ciondolo d’argento antico lavorato che ha subito indossato, malgrado le abbiano preconizzato ogni contagio possibile.
In una čajkana alcuni ragazzini accovacciati si scaldano le mani sulla bocca del forno, mentre le madri, in piedi accanto a loro, lanciano piccole grida per richiamare l’attenzione sulle camicie in vendita. Una di loro ha una stella d’oro che brilla alla narice.
Passa un mendicante, prende un po’ di brace con la sua schiumaiola e fa bruciare delle foglie secche di cui offre il profumo.
Nessuno sa che cosa sia la mia Leica, ma appena ini- zio a maneggiarla tutti si precipitano per comprarla. In questa metropoli decaduta l’istinto commerciale è tutto- ra assai vivace. Tutti sgranocchiano qualcosa, mandorle, urjuk, oppure uva comprata sul momento.
Il 29 marzo 1935, un mese e mezzo dopo aver lasciato Pechino, stiamo per partire.
Abbiamo affrancato le nostre lettere per l’Europa all’ufficio postale (tra quanti mesi ne rivedremo uno?).
Se tutto va bene», ho scritto a casa, «tra sei mesi la mia prossima lettera vi arriverà dall’India. Se tra un anno non saprete niente di noi, potrete iniziare a preoc- cuparvi». Bella prospettiva, in un secolo di aerei e di radiogrammi! Non troveremo più mercati. Tutto è stato messo nelle casse o nei sacchi: le formelle di tè pressato e le pezze di stoffa per i baratti con gli indigeni, l’orzo per i cavalli, le selle, i sacchetti da biada, i frustini, le pastoie, le asce, le corde e così via. Ho trascorso le mie serate a cercare di ricordare tutto quello di cui avevo avuto bisogno nelle spedizioni precedenti.
Ho voluto ricorrere all’aiuto di Peter, il quale ha scoperto che mancava un amo per pescare i pesci nei fiumi. A dire il vero, nel Qaidam i corsi d’acqua, segnati sulle carte con linee punteggiate, sono rari e capricciosi. Fortunatamente troveremo dei montoni, che saranno la base della nostra alimentazione.
Ora, nel cortile della casa cinese degli Urech, i cammelli accovacciati vengono caricati lentamente. Un mongolo si è tolto il cappotto di montone e a torso nudo solleva una cassa al petto soppesandola, la appaia a un’altra e le lega entrambe con una corda di crine; poi, con l’aiuto del suo compagno, equilibra il doppio carico sul basto imbottito; quando si maltrattano troppo le sue gobbe, il cammello protesta e grugnisce, sembrando una porta che cigola. Tra i cinesi affaccendati che ci attorniano, Li, con i suoi occhietti quasi chiusi, sembra addormentato e per ora è incapace di capire una sola parola di ciò che gli dice Peter.
Attraversiamo Tangar un’ultima volta, usciamo dalla porta a sud e dall’altra parte del ponte ci congediamo dagli Urech, meravigliosi e premurosi amici. Per confondere i geni malvagi che potrebbero punirci della nostra presunzione, osserviamo scherzando: «Non vi diciamo addio, torneremo tra qualche mese, ricacciati indietro dalla guerra nello Xinjiang o dalle autorità di Lhasa».
Poi ci avviamo verso le grandi solitudini dell’Asia. Il mio buon cavallo – sul quale troneggio seduta su una sella di legno dagli alti arcioni che ho imbottito con il mio sacco a pelo – felice di aver lasciato la scuderia, zigzaga in ogni direzione. Io lo battezzo Slalom pensando ai miei sci, che quest’inverno non userò. Lasciamo il borgo e il suo minareto con i tetti sovrapposti e dirigiamo le nostre cavalcature verso occidente… Dobbiamo soltanto proseguire in questa direzione per raggiungere lo Xinjiang. Per dove, esattamente, e per quanti mesi, non tentiamo neppure di domandarcelo. Io sono tutta presa dalla curiosità per questo futuro incerto, dalla sensazione di essere ormai libera dagli ostacoli degli uomini; tutta presa dalla gioia di sentire che ciascun giorno, d’ora in poi, sarà nuovo, e che nessuno di essi sarà uguale all’altro; tutta presa dalla decisione di osservare, d’ora in poi, una sola regola: quella di camminare diritto davanti a me.