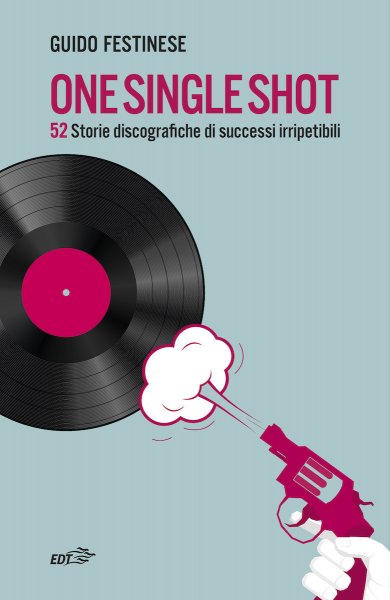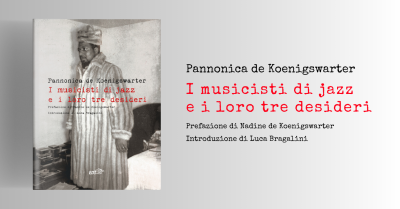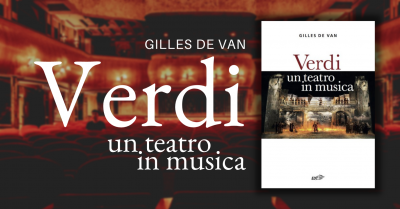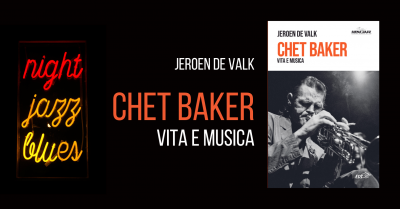Un disco e addio: One single shot, artisti davvero unici

Le storie entusiasmanti e malinconiche delle grandi meteore della musica su disco.
Un solo disco, un solo colpo – come si dice dei cecchini che hanno una sola pallottola per decidere della propria missione, o delle persone che ce l’hanno fatta per una volta sola nella loro vita professionale.
“Cecchini di se stessi”, come dice Guido Festinese questo libro, sono riusciti a dare al pubblico un singolo disco, un LP, un successo magari planetario o magari, anche, solo annunciato, per poi scomparire dalle luci della ribalta.
Storie magiche, incredibili, talvolta inverosimili, di musicisti volenterosi, molto spesso abili tra le sette note, ma che per qualche motivo - congiunture discografiche, litigi, semplicemente la vita che prende strade diverse - non solo non hanno consolidato la propria fama, ma sono usciti completamente dal giro.
Decennio per decennio, la successione di questi 52 successi forma una playlist formidabile – un disco alla settimana per tutto l’anno – ma oltre al piacere della scoperta permette di incontrare una lunga teoria di storie appassionanti di personaggi e gruppi che per una qualche congiunzione astrale hanno vissuto un loro momento di gloria e ne sono rimasti scottati – o per qualsiasi altro motivo non sono più riusciti a ripeterlo. E magari ancora ci stanno provando.
Di seguito, un estratto dal libro: la stravagante e inafferrabile parabola dei Dada, talmente eclettici da perdere la strada.
Guido Festinese è giornalista professionista, docente, saggista, scrittore. Ha collaborato con molte riviste e testate specializzate e non (tra le altre “Musica Jazz”, “Leggere”, “World Music Magazine”, “Monografie”, Radiotre, “Alfabeta”, Radio Svizzera Italiana), e da molti anni collabora stabilmente con “Alias” de “Il Manifesto”, “Audioreview” e “il Giornale della Musica”. Per quasi vent’anni s’è occupato di divulgazione jazzistica al Museo del Jazz G. Dagnino e dal 2015 al 2021 è stato docente di Storia del Jazz ed Estetica delle musiche afroamericane al Conservatorio Paganini di Genova. Ha all’attivo, oltre a migliaia di articoli, una quindicina di testi. Negli ultimi anni s’è dedicato anche alla scrittura per il teatro musicale e alla narrativa.
l disco splendido non ha titolo se non il nome del gruppo: ovviamente, Dada. Il primo elemento da sottolineare è l’efficacia diretta e brutale della copertina. C’è un vecchio grammofono a manovella, con tanto di braccio pesante e settantotto giri in gommalacca poggiato sul cubone di legno, c’è la regolamentare e sovradimensionata tromba per amplificare quello che la puntina trasmette, strofinando nelle pieghe voluttuose dei solchi. Ma c’è di più: l’enorme tromba diventa in sostanza una bocca, perché da lì sporge, vogliosa e gocciolante, decisamente maleducata, una lingua rosa beffarda. Immagine assai impertinente.
Ricorda qualcosa? Certo, ricorda uno dei “loghi” più famosi del mondo per una rock band, quello dei Rolling Stones. E allora, come stanno le cose? Andiamo a verificare un po’ di cronologia. La celeberrima linguaccia rossa disegnata (“Tongue and lips” logo) che richiama quella reale di Mick Jagger comparve la prima volta nella confezione interna in un disco che di spregiudicatezza sexy faceva uso e abuso, il mitico Sticky Fingers con tanto di cerniera reale su jeans disegnati in copertina, genialata di Andy Warhol.
L’aveva concepita, raccontano le cronache, un oscuro studente del Royal College of Art, John Pasche, che a quanto pare trasse ispirazione dall’iconografia della dea indiana Kali, e dalla bocca smorfiosa di Jagger. Il disegno di Pasche fu poi perfezionato da Craig Braun, che lavorava nel settore discografico, e per la precisione nel packaging, la confezione che deve invogliare all’acquisto.
Pare che al ragazzo “Tongue and Lips” fruttò cinquanta sterline, diventate ventiseimila quando gli furono riconosciuti, tre lustri dopo il disegno, i diritti veri dell’immagine. Il bozzetto originale, venduto a cinquantamila sterline, è oggi al Victoria and Albert Museum di Londra. Questa la storia.
Non torna qualcosa? Lo sappiamo, il mondo della popular music è fatto anche di furti e sottrazioni indebite. Molte volte, assai meno colpevolmente, di atti non voluti e/o di presa in carico di frutti della creatività altrui, perché tanto “erano nell’aria”.
In fin dei conti anche il prisma ottico di Dark Side of the Moon ha illustri e assai meno noti predecessori, se si vanno a controllare le date. Occhio alla cronologia, ora: il logo linguacciuto dei Rolling Stones appare nel 1971. La copertina sfrontata di Dada, il gruppo da un solo disco, nel 1970. Se ne traggano le debite e ovvie conclusioni andando a confrontare i due simboli. Bene, è tempo di parlare dei musicisti e della musica. Che è ancora qui a raccontarci una storia fremente e intensa di anni in cui i confini fra i generi saltavano come un plotone di grilli felici su un prato, e più si aumentava il tasso di intrusione stilistica in territori “altri”, meglio era.
Praticamente il contrario delle nicchie musicali monomaniacali e iper specialistiche dell’oggi. L’eclettismo di Dada oggi è piacevole e gustoso, al riascolto. Ma per realizzarsi davvero, curiosamente, ha avuto bisogno che nel dispiegarsi della storia si avverasse una delle balzane profezie e dichiarazioni di un membro di Dada stesso, il movimento: «Dada sopravviverà soltanto cessando di esistere». «Non c’è una direzione precisa», «Ci sono troppi stili stipati in un solo disco»: così Pete Gage, chitarrista e bassista del gruppo, racconta, mezzo secolo dopo, i commenti degli “executives” discografici e dei manager all’a- scolto del disco. Eppure, precisa lui, mica avevano scelto quel nome per nulla.