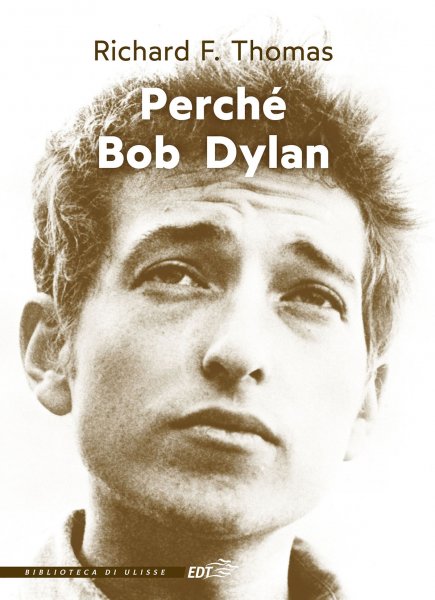Bob Dylan, i perché di un Nobel
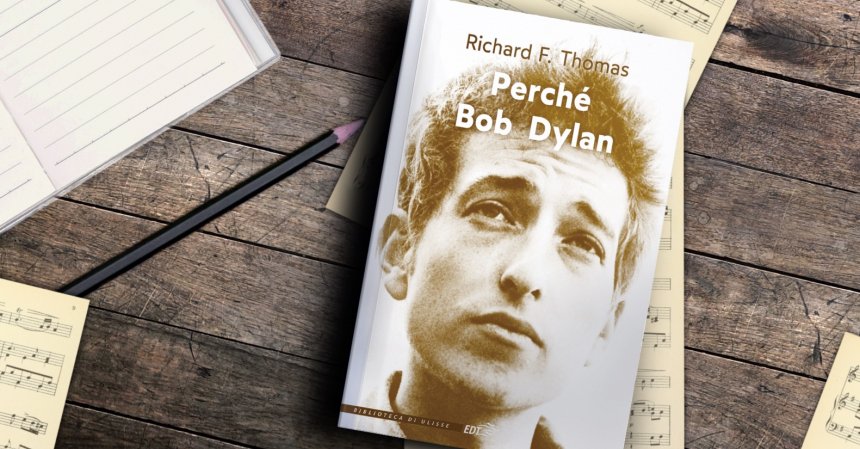
Uno dei più originali contributi alla comprensione dell'opera di Bob Dylan usciti negli ultimi vent'anni. Un libro leggibile e appassionato che dimostra una volta per tutte come l'opera di Dylan sia quella di un grande autore della tradizione poetica occidentale.
Quando nel 2016 a Bob Dylan fu assegnato il premio Nobel per la letteratura, in tutto il mondo divampò un dibattito sull’opportunità di considerare l’opera del grande cantautore americano “vera letteratura” o meno. In un libro brillante e personale, Richard Thomas fornisce una risposta originale quanto magistrale al quesito.
Thomas ripercorre l’intera carriera di Dylan, mostrando quanto profondi siano i legami che, accanto alle più note radici nel folk e nel rock americano, uniscano Bob Dylan ai grandi autori della classicità. Oltre a evidenziare le molte e sorprendenti citazioni letterali nascoste nei suoi testi, Thomas dimostra come il carattere stesso della ricerca artistica di Dylan si situi in quella che si potrebbe dire la grande corrente dei classici occidentali: il modo di porsi di fronte alle grandi domande della vita, la pietas, il valore della poesia e la sua intonazione, il modo stesso di pensare all’umanità.
Richard Thomas dimostra non soltanto di conoscere la musica e la poesia di Dylan come nessun altro, ma fornisce una chiave di lettura di quest’opera enigmatica e appassionante che riesce a cambiare in profondità il nostro modo di ascoltarla.
Richard F. Thomas, docente di Letteratura classica nella Harvard University, è autore di molti prestigiosi contributi allo studio dei classici latini, in particolare Orazio e Virgilio, di cui ha curato anche un importante commentario alle Georgiche (Cambridge 1988). Da molti anni tiene un popolarissimo seminario su Bob Dylan riservato agli studenti di lettere classiche nella Harvard University.
Come molti miei coetanei cresciuti negli anni Sessanta, il primo Dylan di cui feci esperienza fu quello delle canzoni a sfondo sociale. A tredici o quattordici anni cantavo “Blowin’ in the Wind” con il coro della mia scuola in Nuova Zelanda. Tratta dal suo primo album di composizioni originali, The Freewheelin’ Bob Dylan, quella canzone fu la mia prima vera introduzione alla sua musica, anche se ne conoscevo già la versione portata in vetta alle classifiche dal trio folk Peter, Paul & Mary. Cantandola insieme al mio coro, ricordo di aver trovato un po’ fastidiosa l’“aggiunta” prima di ogni domanda delle parole “Yes ’n’”, che invece non c’erano nella versione che avevo registrato dalla radio (per intenderci: “Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail” e così via). Lo feci notare al nostro maestro, ma a quanto pareva lui era già un fan di Dylan, perché si impuntò: il pezzo andava cantato così com’era interpretato in Freewheelin’, e nel giro di poco finii anch’io per preferire quella versione.
Potevamo cantare e fare nostra quella canzone in Nuova Zelanda perché “Blowin’ in the Wind” non apparteneva a nessun luogo o tempo specifico, o meglio, era un appello alla giustizia e alla pace adatto a ogni luogo e ogni tempo. A distanza di pochi anni, nel 1969, la canzone assunse un significato nuovo e più personale per me, quando mi unii come membro dell’organizzazione studentesca HART (Halt All Racist Tours) alle proteste contro la partecipazione della nazionale neozelandese ai campionati di rugby disputati nel Sudafrica dell’apartheid. A quel punto la rilevanza di “Blowin’ in the Wind” aveva superato i confini ristretti del movimento americano per i diritti civili che in origine l’aveva ispirata. Ormai parlava anche di Nelson Mandela e degli altri militanti che il regime dell’apartheid aveva condannato all’ergastolo e ai lavori forzati su Robben Island – un luogo di confino chiaramente visibile dalle splendide spiagge di Cape Town.
Fino al 1967 la Nuova Zelanda selezionava per razza i giocatori della nazionale da mandare a competere con le squadre di soli bianchi del Sudafrica. Ai maori era concesso di giocare in virtù dello status di “bianchi onorari”. Era quasi inevitabile pensare ai versi della canzone – “Yes, ’n’ how many times can a man turn his head | Pretending he just doesn’t see?” (“E un uomo quante volte può voltarsi | e far finta di non avere visto?”) – mentre partecipavo alle manifestazioni. “Blowin’ in the Wind” diventò il nostro inno anche nelle proteste contro il coinvolgimento – militarmente insignificante ma simbolicamente rilevante – del mio paese nella guerra del Vietnam: “Yes, ’n’ how many times must the cannonballs fly | Before they’re forever banned?” (“E le palle di cannone quante volte dovranno volare | prima di abolirle per sempre?”).
In quelle circostanze la canzone dimostrò la stessa pertinenza che aveva avuto nella marcia su Washington, il più oceanico dei raduni per i diritti civili, inscenato il 28 agosto 1963. In quell’occasione erano stati Peter, Paul & Mary a interpretarla, mentre Dylan aveva cantato due pezzi tratti da un nuovo album ancora inedito, The Times ey Are A-Changin’: prima “When the Ship Comes in”, insieme a Joan Baez, e poi “Only a Pawn in Their Game”, da solo. Ma a dispetto del suo ruolo storico in momenti come questi, né allora né oggi “Blowin’ in the Wind” si può etichettare soltanto come canzone di protesta. Fin dalla prima esecuzione ufficiale, nell’aprile 1962, al Gerde’s Folk City del Greenwich Village, Dylan ha cercato in ogni modo di liberarla da quel compartimento stagno. Ecco in quali termini il cantautore – va sottolineato, perché questo era Dylan: un cantautore, non un militante – la presentò allora:
"La prossima non è una canzone di protesta o niente del genere, perché io non scrivo canzoni di protesta [...]. L’ho scritta soltanto come qualcosa che si potrebbe dire, per qualcuno, da parte di qualcuno".
Troppo tardi. Per citare il poeta latino Orazio (65-8 a.C.), “una parola detta prende il volo, senza rimedio” (Epistole, I, 18, a Massimo Lollio).