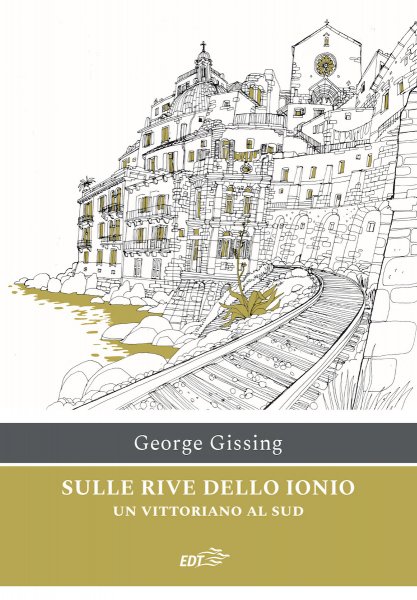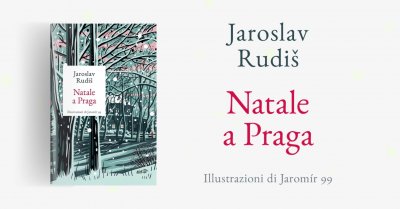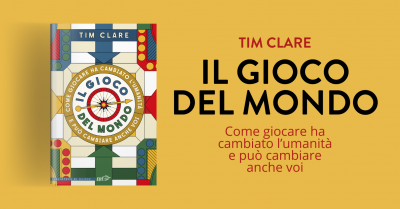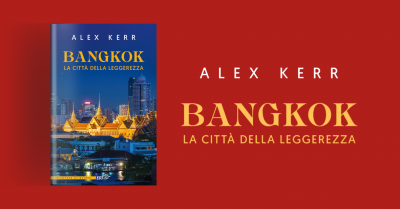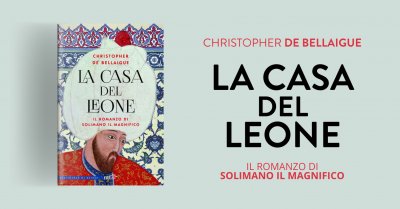George Gissing sulle rive del Galeso
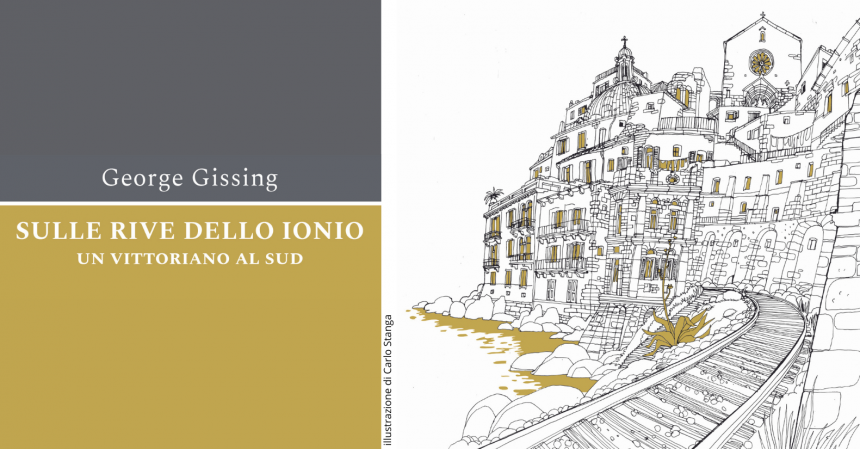
Il fiume Galeso scorre presso Taranto. È cortissimo, meno di un chilometro, eppure ha ispirato alcuni dei più grandi poeti dell’antichità.
Orazio, lontano dall’amata Tivoli, nell'Ode 6 A Settimio si augurava di trovare conforto presso «le dolci acque del Galeso caro alle pecore avvolte nelle pelli […] Quell’angolo di mondo più d’ogni altro mi sorride». E Virgilio ambientò lungo il fiume una scena delle Georgiche, l’incontro con un vecchio contadino, proprietario di un piccolo terreno infruttuoso, ma capace di trarne il meglio e di vivere sereno: «ricordo sotto le torri della rocca Ebalia, per dove il bruno Galeso bagna bionde coltivazioni, di aver veduto un vecchio di Corico […] uguagliava nell’animo le ricchezze dei re».
Queste rappresentazioni del Galeso sembrano uscire da quello «scrigno di memorie eterne» di cui parla Mauro Francesco Minervino nell’Introduzione a Sulle rive dello Ionio, il resoconto del viaggio che lo scrittore vittoriano George Gissing intraprese nel Mezzogiorno d’Italia nel tardo autonno del 1897. Come altri viaggiatori suoi contemporanei, Gissing era mosso dal desiderio di immergersi nella meravigliosa eredità del mondo classico, di ricalcare le orme dei greci e dei romani: il viaggio mise queste alte ispirazioni alla prova della realtà concreta di un paese povero, dal clima impossibile, dove il contrasto tra modernità ed epopea classica non avrebbe potuto essere più stridente. Questa Calabria reale, in ogni caso, non sembrerà all’autore meno interessante di quella fantasticata prima di partire.
Il Galeso di fine Ottocento, inevitabilmente, non è come quello della poesia classica, ma Gissing non si abbatte: nel ricordo non c'è delusione, e quello che non si è visto si può sempre immaginare.
Chi potrebbe trovarsi a Taranto e non rivolgere il pensiero al Galeso, col desiderio di camminare sulle sue rive? Purtroppo vi è grande incertezza sulla sua posizione. C’è un corso d’acqua che sbocca nel Mar Piccolo e alcuni lo chiamano Galeso, ma i contadini comunemente gli danno il nome di Gialtrezze. Naturalmente rivolsi i miei passi in quella direzione per andare a vedere di persona.
Per costeggiare la riva occidentale del Mar Piccolo dovevo oltrepassare la stazione ferroviaria, e là chiesi qualche informazione; il ferroviere col quale parlai non conosceva il nome Galeso, ma mi disse che il Gialtrezze sboccava in mare a una distanza di circa tre chilometri. Il fatto che mi proponessi di fare quella camminata per vedere un fiumiciattolo da nulla provocò sorpresa e perfino un’amichevole preoccupazione nel mio interlocutore, che mi dichiarò più volte che non valeva la pena, ripetendo con enfasi: «Non c’è novità». Ma feci a modo mio, da quello sciocco che ero. A due o tre contadini o pescatori che incontrai cammin facendo chiesi il nome del fiumicello a cui mi avvicinavo; risposero: «Gialtrezze». Poi passò un uomo con un fucile, e il suo sorriso e il suo saluto mi invogliarono ad interrogarlo. «Mi sa dire come si chiama il fiume che sbocca in mare qui vicino?» «Signore, è il Galeso».
La gioia mi accelerò le pulsazioni del sangue; tanto più quando mi resi conto che il mio informatore non aveva neppure un’infarinatura dei classici e che la scelta fra Galeso e Gialtrezze era per lui solo una questione d’interesse locale. Lo salutai lietamente e poco dopo fui in vista del fiume. Fiume? Sarà lungo appena mezzo miglio; nasce in un letto di grandi canne che nascondono completamente la sua acqua e scorre con una larghezza media di un paio di metri fino al mare, avendo di qua e di là campi brulli e polverosi e qualche grigio ulivo.
Questo, il Galeso? Il fiume amato da Orazio, sulle cui rive trovava pascolo una famosa razza di pecore con un vello così pregiato che veniva protetto da una gualdrappa di cuoio? È certo che tutte le acque della Magna Grecia sono molto scemate dall’età classica ad oggi, ma – a meno che non vi siano stati grandi cambiamenti nella struttura del terreno, dovuti, per esempio, a terremoti – questo ruscello deve sempre avere avuto la stessa lunghezza ed è difficile pensare che il Galeso fosse così insignificante. Deluso e pensoso seguii la corrente fino al mare e sulla riva, tra un profumo di menta e rosmarino, sedetti a riposarmi.
Di là dalle acque si godeva una bella vista di Taranto; la città vecchia sulla sua isoletta, un intrico di case bianche in contrasto con le tinte giallastre dei grandi edifici moderni che invadevano la parte peninsulare. Socchiudendo gli occhi si poteva immaginare la vera Tarentum. Piccole onde davanti a me lambivano la sabbia, con una musica identica a quella di duemila anni fa. Passò un capraio seguito dal suo gregge sparpagliato; l’uomo e le capre appartenevano tanto al mondo antico quanto a quello nuovo. In lontananza le barche dei pescatori scivolavano silenziosamente sull’acqua. Sentii un fruscio: da un vecchio fico lì vicino cadevano le ultime foglie. Sull’argine di terra gialla, screpolata, lucertole mi schizzavano intorno, al sole. Dopo una mattinata coperta, il giorno era diventato sereno e dorato, terra e cielo erano immobili, come in un’eterna pace.
«A me è più caro di tutti quel lembo di terra che non cede all’Imetto per il miele, né al verde Venafro per l’ulivo; dove il cielo concede una lunga primavera e tepore nell’inverno; e nelle valli assolate Bacco nutrisce una vendemmia nobile come il Falerno». I versi di Orazio mi risuonavano nella mente, pensai anche alle lodi di Virgilio, che, secondo una tradizione, avrebbe scritto le Egloghe in questi dintorni. Certo l’aspetto della regione è molto diverso in inverno e all’inizio dell’estate; io la vedevo in un momento sfavorevole; ma, anche facendo le più ampie concessioni alla stagione, il ricordo dell’entusiasmo di quei poeti suscita sempre stupore. Deve esserci stato un cambiamento inimmaginabile su queste rive dello Ionio. Sembrava che il profumo di rosmarino venisse a me, attraverso i secoli, da un mondo svanito.
«A me è più caro di tutti quel lembo di terra che non cede all’Imetto per il miele, né al verde Venafro per l’ulivo; dove il cielo concede una lunga primavera e tepore nell’inverno; e nelle valli assolate Bacco nutrisce una vendemmia nobile come il Falerno». I versi di Orazio mi risuonavano nella mente, pensai anche alle lodi di Virgilio, che, secondo una tradizione, avrebbe scritto le Egloghe in questi dintorni. Certo l’aspetto della regione è molto diverso in inverno e all’inizio dell’estate; io la vedevo in un momento sfavorevole; ma, anche facendo le più ampie concessioni alla stagione, il ricordo dell’entusiasmo di quei poeti suscita sempre stupore. Deve esserci stato un cambiamento inimmaginabile su queste rive dello Ionio. Sembrava che il profumo di rosmarino venisse a me, attraverso i secoli, da un mondo svanito.
Dopo tutto chissà se avevo davvero visto il Galeso? Forse, come dicono certuni, si tratta di un altro fiume, che sfocia, molto a ponente di Taranto, nel mare aperto. Il Gialtrezze può essere diventato Galeso solo per il desiderio che avevano alcuni eruditi di identificarlo col fiume classico; nello stesso modo tanti nomi arbitrari sono stati imposti in altre parti d’Italia. Ma non presterò orecchio a una tesi così scoraggiante. Non è probabile che io possa mai rinnovare le mie ricerche, e per me il Galeso – dulce Galaesi flumen – resta il ruscello che trovai e seguii e di cui vidi le acque mescolarsi con quelle del Mar Piccolo. Nel ricordo non c’è più delusione. Quelle canne fruscianti intorno a una fonte segreta mi sembrano una dimora degna di una Naiade; sono contento di non essere riuscito a vedere l’acqua sgorgare alla sorgente, perché così rimane un mistero. Finché vivrò, il Galeso mormorerà e brillerà alla luce di quel pomeriggio dorato, e laggiù, oltre le profondità azzurre e silenti, apparirà una tenue visione di Tarentum.