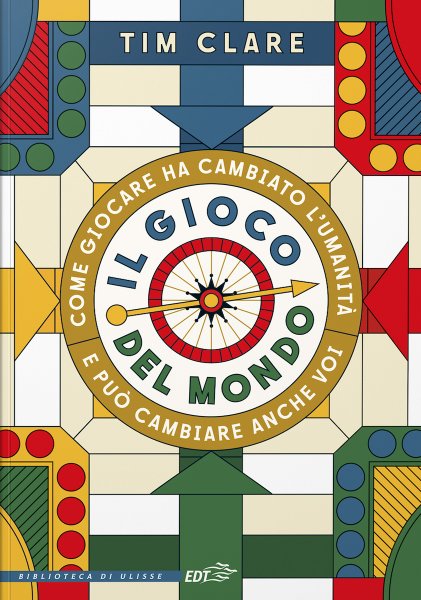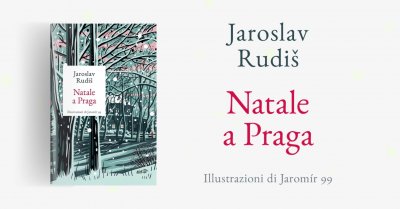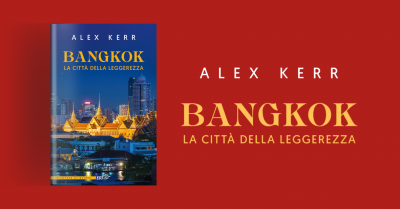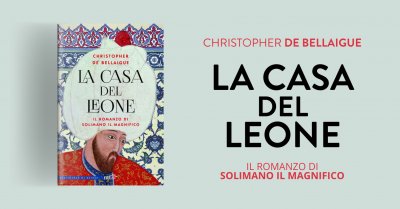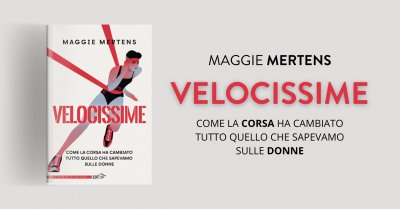Siamo nati per giocare
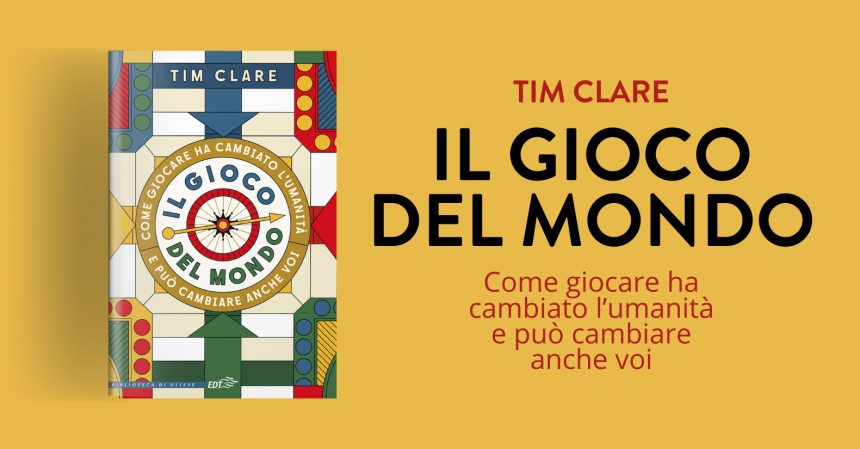
Sosteneva Friedrich Schiller che l'uomo è interamente uomo solo quando gioca. Tim Clare è d'accordo: il gioco, così importante perché non necessario, così privo di rilevanza da esercitare autentico potere, è una modalità di comportamento umano che non si trova da nessun'altra parte.
In questo brano, tratto dall'Introduzione a Il gioco del mondo, l'autore parla della presenza dei giochi in tutte le civiltà, della loro capacità di dare forma al presente al di là di classi, generi ed etnie, di come riescano a creare legami in un'epoca di isolamento, incertezza e frammentazione.
In questo libro non voglio offrire qualcosa di sciocco come una difesa dei giochi da tavolo. Tanto varrebbe difendere la respirazione, o la Luna. Non si può impedire agli esseri umani di giocare.
Nel 2013 alcuni archeologi hanno scoperto nel Sud-Est della Turchia un sito funerario dell’Età del Bronzo, risalente a 5000 anni fa, che conteneva – insieme ad altri oggetti presenti nelle tombe – 49 pezzi da gioco di pietra scolpita. Comprendevano piramidi, pedine a forma di ogiva con base piatta, gettoni circolari e – cosa piuttosto commovente – dei cagnolini e dei porcellini. Cinque millenni fa, prima della democrazia, prima della fondazione di tutte le principali religioni del mondo, prima ancora che gli esseri umani concepissero un alfabeto scritto (l’esempio più antico è l’alfabeto proto-sinaitico, comparso circa 1000 anni dopo), stavamo già lanciando dadi e spostando un cagnolino su un tavoliere.
E non è una cosa ovvia, no? Pensando ad attività come l’adorazione del sole, i riti funebri, la rappresentazione in ceramica, bronzo o pittura rupestre delle cose che ci circondano, non ci vuole una grande fantasia per immaginare che una piccola comunità primitiva le potesse incontrare in modo del tutto naturale. Ma lanciare dei dadi, muovere dei pezzi – semi, sassi, oppure oggetti scolpiti appositamente – su una griglia, un percorso o una serie di zone delimitate, come forma di competizione ritualizzata, insieme al fatto che rituali decisamente simili si presentino in tutto il pianeta, in ogni società, appare come qualcosa di meno inevitabile, come se riaffiorasse invece da qualche invisibile falda acquifera della psiche umana.
«Dove si trova una civiltà, lì si trovano anche i giochi», mi ha detto la professoressa Lanah Haddad, archeologa della Goethe-Universität di Francoforte e progettista di giochi. «Quando le persone iniziarono a vivere insieme nei villaggi, e in particolare nelle città, sentirono il bisogno di sviluppare capacità che non erano necessarie agli agricoltori o ai cacciatori-raccoglitori». I giochi da tavolo, sostiene l’archeologa, ci insegnano a destreggiarci tra i rapporti umani e le vicissitudini della vita.
Nel 3100 a.C., un insediamento nascosto in un’ansa del fiume Tigri serviva da centro amministrativo della regione. Era un sito popolato fin dal 10.000 a.C. Gli abitanti usavano sigilli cilindrici per stampigliare marchi nell’argilla umida, forse per registrare transazioni: un timbro da notaio dell’Età del Bronzo. Ci possiamo immaginare un burocrate, sfinito da giorni e giorni di certificazioni per il passaggio di proprietà di bestiame, pietre preziose, vasi in ceramica e manufatti in bronzo, seduto all’ombra della pietra dell’ufficio registrazioni insieme a un mercante o a un pastore, che estrae dei dadi e una tavola di legno, oppure ne disegna una nel terreno con un sasso, e dispone con cura i pezzi per rilassarsi con una partita del gioco che alcuni archeologi hanno chiamato “cani e maiali”.
Se do un’occhiata alla mia sinistra, sulle mensole di casa mia vedo giochi con pedine, piramidi in miniatura e, in effetti, anche piccole rappresentazioni scolpite di cani e maiali. Questi elementi del gioco sono sopravvissuti più a lungo di dinastie, imperi, lingue e interi sistemi di credenze.
I giochi hanno costruito e cambiato il mondo. E possono cambiare anche noi, in modi lievi e profondi. Spero che que- sto libro dimostri che a giocare non è un tipo particolare di persona. Non ci sono una classe sociale, un genere e un’etnia privilegiati. Chiunque tu sia, un posto al tavolo è un tuo di- ritto di nascita.
Siamo nati per giocare. È questo il bello. Quando ci sediamo per prendere parte a un gioco, operiamo di concerto con i nostri bisogni più profondi, anche se le batoste e le pressioni della vita ci hanno reso questi bisogni un po’ estranei, qualcosa di cui vergognarsi un po’. Le connessioni che creiamo al tavolo non si limitano alle persone intorno a noi, ma sono con i nostri antenati, con tutta l’umanità.
Nei Racconti di Canterbury, quando Chaucer parla di persone che «giocano turpemente» d’azzardo e ci mette in guardia rispetto al danno inflitto alla reputazione di re e principi da «un paio di dadi», il gioco che sta descrivendo è lo stesso a cui si riferisce sei secoli più tardi Warren G in “Regulate”, quando incontra per strada «some brothers shootin’ dice». La differenza tra il gioco descritto in Chaucer e gli street craps è talmente minima – solo un paio di regole – che Warren G ci impiegherebbe 30 secondi o poco più per mettere al passo Geoffrey C e permettere al minuto burocrate inglese di giocare a dadi in tutte le strade della West Coast.
Di questi tempi è facile sentirsi isolati, frammentati, incerti sul proprio passato, la propria eredità, le persone che possiamo chiamare comunità, il posto a cui apparteniamo. I giochi dissipano questa illusione di separazione. Per gli antichi Egizi, erano un ponte. Per me sono un bazar animato. Tesori e segreti e persone di tutte le terre e di tutti i tempi convergono in un turbine spumeggiante di emozioni e idee.
Guarda, sussurra quel luogo. Siamo tutti collegati.